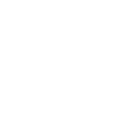X Anniversario della Consacrazione Episcopale
Chiesa Cattedrale, 5 dicembre 2025 – Venerdì della I Settimana di Avvento
Omelia Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo
Sorelle e Fratelli nel battesimo, nel presbiterato, nel diaconato, nell’amicizia,
da dieci anni Cristo, Sposo della Chiesa, ci dona di celebrare assieme l’Eucarestia. Ci dona di costruire assieme una storia santa nel ‘già e non ancora’ del Regno di Dio, del Dio che è venuto, che viene e che verrà. Da dieci anni siete entrati nel mio cuore e da dieci anni busso e sono accolto nel vostro cuore.
In questa Santa Sinassi – arricchita con profonda nostra gioia dalla presenza dei carissimi fratelli nell’episcopato e dell’abate di S. Martino – sentiamo e viviamo una ‘gratitudine eucaristica’ che significa reciprocità. Quella reciprocità che dobbiamo riscoprire sempre di più, poiché dimoriamo tutti nel cuore di Cristo. E Lui è nel cuore di ognuno di noi. Ecco, vorrei dirvi stasera quanto stupore, quanta emozione, quale senso di responsabilità hanno riempito il mio, di cuore, quando l’indimenticabile, amatissimo Papa Francesco – amatissimo perché profeta del Vangelo nel nostro tempo, annunziatore della sua freschezza – mi chiese di lasciare il ‘piccolo orto’ che curavo con affetto, a San Pietro, in Modica, per donarmi e affidarmi un giardino così grande, così bello, così impegnativo come la Chiesa di Palermo.
E sono venuto qui, consapevole che questo giardino, questa Chiesa di Palermo era già stata a lungo coltivata dai miei predecessori e che il mio compito era quello di continuare, di fare un pezzo di strada con voi. Così ho ricordato subito i Pastori che mi hanno preceduto, da Mamiliano ai giorni nostri: i giorni dei cardinali Ernesto Ruffini, Francesco Carpino, Salvatore Pappalardo, Salvatore De Giorgi, fino al cardinale Paolo Romeo che 10 anni fa mi consacrava in questa cattedrale. Ricordarli, nella gratitudine e nella preghiera, era ed è un modo di esprimere il nostro ‘grazie’ al Pastore e Sposo della Chiesa, che non smette mai di prendersi cura della sua Sposa. Essa cammina nella storia sostenuta dal suo amore, dal suo perdono, dalla sua consolazione.
Secondo la nota espressione di Papa Ratzinger, noi pastori siamo «semplici e umili lavoratori nella vigna del Signore» (19 aprile 2005), chiamati, a ogni ora della giornata, della lunga giornata della storia, a dire e a ridire, a noi stessi innanzitutto, e a tutti voi, la Parola del Dio che è Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Messia. Siamo chiamati a costruire e ricostruire con voi e per voi, ogni giorno, la comunità, il corpo di Cristo che è la Chiesa, nella sua variegata e preziosa composizione di ministeri e carismi, il corpo del mondo nel quale la Chiesa è lievito e segno di salvezza per tutti (cfr LG 1). Nel succedersi dei vescovi della nostra amata Chiesa palermitana vediamo insomma la presenza fedele di Cristo Sposo, che non abbandona la sua Sposa anche quando è fragile e debole.
È come levare un inno alla durata, alla fedeltà, che esige insieme novità. Ogni nuovo pastore, infatti, ha il compito della continuità e della creatività. Quella creatività che per Papa Giovanni XXIII coincideva con la lettura dei segni dei tempi, perché sono i tempi della storia, i tempi in cui viviamo, a rivelarci ogni volta quale parola, quale messaggio, quale senso dell’Evangelo sia rimasto trascurato nel cammino finora compiuto. Se il Regno di Dio è nel “già e nel non ancora”, allora ogni pezzo di strada è segnato da fedeltà e infedeltà ai segni del Regno. Scoprire le infedeltà sommerse, quel nostro mancare al Vangelo, magari senza che ce ne accorgiamo, è il compito di ogni nuovo inizio e, in particolare, del tempo liturgico dell’Avvento.
E all’Avvento ci riportano le letture bibliche di oggi. Veniamo ricondotti al sogno che abita nel cuore di ogni uomo. Il sogno che qualcuno venga. Che ci sia soccorso. Che per le nostre lacrime, per la nostra fatica di vivere giunga un rimedio. Non speriamo in una medicina, in una pozione magica, bensì in una presenza. L’Avvento è questa speranza, che Dio non ci abbandoni, che Dio si ricordi di noi, che la venuta del suo Figlio, nella debolezza, nel ‘nulla luminoso’ di Betlemme, sia anticipo, caparra del compimento del Regno, del suo Ritorno glorioso.
La parola che abbiamo ascoltato nutre questa speranza, la rafforza. Siamo sordi, siamo ciechi, ci ricordano Isaia e Matteo. È inutile nascondercelo. Se guardiamo alla nostra Palermo, alla nostra Sicilia, all’Italia e, direi, al mondo intero, nel suo assetto odierno, ci rendiamo conto di come si stenda su di noi la coltre della sordità, come ci blocchi l’impaccio della cecità. Se ascoltassimo l’appello che ci giunge dal fratello, dalla sorella, dal loro volto sfigurato, sfinito dalla guerra, dalla povertà, dalla violenza; se aprissimo gli occhi sul peccato contro lo Spirito, che è pensare e vivere la vita come un conflitto distruttivo e infinito, in cui i più forti prevalgono sui più deboli, in cui i potenti senza scrupoli e i mafiosi prevaricano sulla gente, spargendo paura, miseria, terrore, morte; se non ci girassimo dall’altra parte, rifugiandoci nel nostro cantuccio, rifiutando di metterci assieme, di ‘com-patire’ e lottare con tutti, di creare dal basso – da quella terra in cui germoglia il granellino di senapa e sboccia in silenzio il frutto del Regno (cfr Mt 13,32; Mc 6,26-29) – i presupposti di un mondo nuovo, tutto sarebbe diverso, il profilo della vita sarebbe nella luce.
La parola del Signore giunge stasera ad annunciarci che il risveglio, l’ascolto, la vista non sono un’utopia. Che Lui viene a guarirci. Senza orecchi che odono e occhi che guardano, il Regno non giunge. Una nota preghiera dice: «Cristo non ha mani ha soltanto le nostre mani per fare oggi il suo lavoro. Cristo non ha piedi ha soltanto i nostri piedi per guidare gli uomini sui suoi sentieri. Cristo non ha labbra ha soltanto le nostre labbra per raccontare di sé agli uomini di oggi. Cristo non ha mezzi ha soltanto il nostro aiuto per condurre gli uomini a sé oggi. Noi siamo l’unica Bibbia che i popoli leggono ancora siamo l’ultimo messaggio di Dio scritto in opere e parole» (Autore fiammingo del XIV secolo, ripresa da Raoul Follereau). Il Regno non è un miracolo, ma è l’imprevedibile atteso, l’impossibile che accade, l’imprevisto impensabile, quando le donne e gli uomini della Terra, senza barriere di alcun tipo, diventano, come Gesù, samaritani delle creature, delle loro sorelle, dei loro fratelli. Quando si fanno soccorritori delle piaghe dell’altro, lenitori delle sue ferite, quando vivono la fraternità, la «perfetta letizia» di Francesco d’Assisi (FF 1836; cfr Gc 1,2) – ricordiamolo stasera con affetto grande, mentre stanno per compiersi ottocento anni dal suo ingresso nella luce dell’Eterna Letizia –, la gioia di un dono che non vuole ricambio, di una gratuità aperta a ogni evento, di un tocco che guarisce ogni cecità: «Allora toccò loro gli occhi […] e si aprirono loro gli occhi» (Mt 9,29.30).
È riposta qui la speranza dei poveri e degli umili. Ogni volta che il nostro suolo fiorisce e un gesto arriva a toccare il dolore dell’altro – come fece l’uomo di Samaria (cfr Lc 10,29-35), come ha fatto Gesù di Nazareth per tutti noi – allora torna la gioia. Il mondo si rovescia. I poveri non sono oppressi e gli umili non vengono derisi. Piuttosto «si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo di Israele» (Is 29,19). Dio opera tutto questo ma non per magia. Lui ci spinge e ci sostiene, in silenzio. Lui ci dona forza. Lui è il Signore della storia, l’Assente più che mai Presente nei nostri corpi, nelle nostre vite, in ogni epifania dell’agape, della carità.
Isaia ci spiega stasera infatti che non dobbiamo avere paura: «Perché il tiranno non sarà più, sparirà l’arrogante, saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla» (Is 29,20-21). La storia non sarà infine lo spazio di quelli che spadroneggiano, che credendo di mostrare i muscoli altro non fanno se non mostrare la loro insicurezza e il loro fallimento. E con loro spariranno i cantori della colpa. Sono tutti quelli che sciorinano lamenti e magari improperi sul mondo perduto. Non conoscono altra via che quella di dar la colpa agli altri: del degrado, dell’ingiustizia, del soffrire. Papa Giovanni XXIII li chiamava «profeti di sventura, che annunziano sempre il peggio» (Gaudet Mater Ecclesia, 11 ottobre 1962), Dietrich Bonhoeffer «eterni insoddisfatti» (Bilancio sulla soglia del 1943 – Dieci anni dopo, in Resistenza e resa). Entrambi, da autentici discepoli del Vangelo, sapevano che i cristiani non sono nel mondo per accusarlo, per lamentarsene, per condannarlo come un luogo di perdizione o di oblio della religione e dello spirito. I cristiani non sono dei moralisti. I cristiani sanno che se non fai parte della soluzione, fai parte del problema. Cristo, pur innocente, ha donato la soluzione consegnandosi liberamente e per amore al Padre e ai fratelli nella comunione dello Spirito (cfr Gv 6,38; 13,1-2). Non siamo superiori agli altri. Viviamo accanto a tutti, per gioire dell’essere alla vita e per ‘con-gustare’ la misericordia di Dio e sanare insieme le colpe, le uniche colpe reali, generate da relazioni ferite, da infanzie catastrofiche, da ingiustizie strutturali, da strutture di peccato. Per vivere e annunciare la potenza del Vangelo che parla a tutti, che guarisce tutti, che sorride a tutti, anche ai pubblicani e ai peccatori, chiamati a non sprecare la vita e a sedersi a tavola con il Figlio dell’Altissimo (cfr Mt 9,9-13). C’è una sapienza diversa da quella della fredda osservanza religiosa o teorica, la sapienza del fare un passo avanti nel costruire la comunione e un passo indietro nei conflitti. Una sapienza che tiene assieme l’anelito per la giustizia, l’amore fattivo, il dialogo, il coraggio di fronte ai potenti, con la gioia della vita, l’apertura alla bellezza, l’obbedienza vitale al quotidiano, ai giorni che sono i nostri, alla ‘manna del tempo’. Una sapienza alimentata «sul fatto che, da duemila anni, una tradizione religiosa ininterrotta e sempre vivace si è edificata sulla fede che l’infinito si è incarnato» (J.-L. Marion, Credere per vedere, 92).
Uniamoci allora stasera nell’invocazione a Colui che è nostra luce e nostra salvezza. Chiediamogli di aprirci gli occhi, di sturarci le orecchie. E gridiamo. La pagina del Vangelo che abbiamo letto è fulminea e potente. In poche righe l’evangelista riesce a farci entrare, a farci partecipare al movimento dei due ciechi, a farci sentire accanto a loro, come loro.
Chiamandolo «figlio di Davide» (Mt 9,27) i due ciechi connettono il Rabbi di Nazareth alla storia di Israele, alle generazioni che lo hanno preceduto, alla radice da cui è sbocciato, al tronco di Iesse di cui è il virgulto. Colui che è invocato quale Salvatore non è un angelo sceso dal cielo, come un marziano da un pianeta alieno. È una persona, un uomo di carne e di sangue, che si porta dentro, nel suo corpo, la bellezza e l’orrore di una storia lunga, fatta di rivelazioni, di manifestazioni, di parole profetiche, ma punteggiata anche da tradimenti, da guerre, da rivalità selvagge, da violenze inaudite. Il Figlio di Dio – l’«unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre» (Simbolo Niceno-Costantinopolitano) – che si inserisce in una storia apparentemente troppo umana, anche nella storia di Davide, il prediletto di Jahvé che danzò nudo ed ebbro di gioia per l’Arca dell’Alleanza (cfr 2Sam 6,14), ma che con un’assoluta mancanza di scrupoli rubò la bellissima Bersabea a Uria, ordendo un tranello mortale per il soldato fedele (cfr 2Sam 11,1-17). Di Davide costui, il Messia, è chiamato ‘Figlio’: Lui guarisce e trasforma la storia umana, Lui trasforma le foreste selvagge nei giardini, nel «frutteto» dell’incontro con Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo e degli incontri tra uomini e donne, tutte, tutti degni di amore, misericordia e consolazione.
Ecco, i due non vedenti sono quelli che vedono il Cristo: «lo seguirono gridando (κράζοντες): “Figlio di Davide, abbi pietà di noi!”» (Mt 9,27). Matteo ci presenta due ciechi, come a dire che non si è ciechi da soli, che il grido verso il Figlio è un fatto di comunità; come a dire che siamo in tanti a gridare e che questo grido che ci unisce diventa la parola dell’umanità e della Chiesa-Sposa al Suo Sposo.
Il Figlio di Davide, il Messia, interroga i due ciechi, ci interroga: «Credete che io possa fare questo?» (Mt 9,27). Vuole sapere se ci fidiamo. Per essere guariti dobbiamo gridare e fidarci. Non si tratta di una scommessa, ma di una consegna del cuore, nella quale in ultima analisi consiste la fede: credere è ri–cor-dare, riconsegnare il cuore. Anche Paolo ci parla di un grido: «E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo (κράζομεν): “Abbà! Padre!” […] Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio» (Rm 8,15. 26-27). Il verbo usato da Paolo per indicare il grido dello Spirito è lo stesso di quello di Matteo: κράζειν. Il grido è dunque la forma primordiale dell’orazione, la verità della preghiera, che lo Spirito di Dio leva in maniera folle e incomprensibile a nome nostro, gemendo per tutta la creazione ancora oggi segnata dai dolori del parto. Siamo soccorsi già nella preghiera, ciechi nel mondo, soli, magari disperati eppure circondati e abitati da Dio. Raggiunti per dimora nel suo amore (cfr Gv 15,9). È così, con questi sentimenti, che stasera, dieci anni dopo quel 5 dicembre del 2015, vi invito ad andare avanti assieme.
Sorelle e fratelli, Amici, Amiche, di altre fedi e di altre chiese, San Giovanni Crisostomo scrive che Chiesa è «nome che sta per cammino insieme e ordinato (συστήματος καί συνόδου)» (Exp. in Psalm., 149, 1), e “sinodo” in greco significa “camminare assieme” secondo un “ordine” (συστήματος), quello che Agostino ha chiamato una volta per tutte «l’ordine dell’amore» – «vera virtutis est ordo amoris» (De civ. Dei 15, 22) – che è generato e verificato, appunto, dall’amore. Quel cammino sinodale che Papa Francesco ha attivato e Papa Leone XIV sta continuando con lo scopo di coinvolgerci tutti in un cammino di popolo che, nelle diversità di carismi e di ministeri, vuole essere Corpo di Cristo che cerca la Famiglia umana come sua Sposa.
Il nostro pensiero va a Colei che celebreremo dopodomani, a Maria che – come dice Francesco – è «Vergine fatta Chiesa» (FF 259). Lei, esperta dell’attendere, ci precede e ci insegna a essere ogni giorno grembo del Suo Figlio, il dono più bello dell’umanità e della storia, il dono che il cuore nostro e quello di ogni uomo e donna desidera.
Continuiamo l’Eucarestia: che è rendimento di grazie e certezza che voi pregate per me e che io prego per voi nell’abbraccio del Fuoco d’Amore. Con tutto il mio affetto di Padre, di fratello, di amico nello Spirito, che vi esprimo attraverso queste parole di C. Bobin: «Accetto di perdere tutto e che, nel tempo fugace di questa perdita, il nido di rondine che ho nel mio petto sia vuoto, vuoto, vuoto, incantevolmente vuoto e chiamante» (Un cigolio d’altalena, 40).
PHOTOGALLERY 1 (G.Rubino, G. Azzara, R. Immesi)
PHOTOGALLERY 2 (5 dicembre 2015)
PHOTOGALLERY 3 (Cattedrale di Palermo)
LINK DIRETTA 5 dicembre 2025