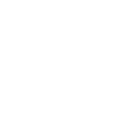Ecco il testo dell’intervento (evidenziati alcuni passaggi in grassetto) che l’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice terrà questa sera alle 21.00 nella basilica di San Domenico nel corso del momento di preghiera per la pace. L’incontro, aperto anche ai rappresentanti di tutte le altre religioni presenti in città, è organizzato da: Arcidiocesi di Palermo, Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali-Ufficio Stampa, Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro, Caritas Diocesana, Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali, Ufficio pastorale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile, Centro diocesano Confraternite, Movimento Pax Christi.
Intervento durante la Preghiera per la pace
Chiesa S. Domenico
Palermo, 4 novembre 2022
Care Sorelle, cari Fratelli,
vi saluto così, in nome di una comune umanità che ci raccoglie qui, stasera, in quanto donne e uomini desiderosi di comunione e di futuro. Comunione e futuro. Perché senza l’esperienza del nostro essere raccolti in una koinonia, in una vita e in un destino che riguardano tutti, non siamo uomini. Senza l’attesa del futuro, senza quell’immediato, corporeo protenderci verso il domani che è tutt’uno con il nostro desiderio di vivere, l’umanità non esiste, l’umano non si dà. Siamo qui stasera interpellati da quanto c’è nella nostra esistenza di più lontano da questo orizzonte costitutivo, e cioè la guerra. Guardiamo stasera all’Europa, dove si è aperta “la ferita” del conflitto in Ucraina. Guardiamo al mondo scosso da guerre lunghe, drammatiche, spesso silenziose e incancrenite. Ho visto con i miei occhi e sentito con i miei orecchi i flagelli della guerra del Congo e della Siria. La nostra casa comune, sempre più piccola e interconnessa, rischia oggi di tradire la propria intrinseca vocazione di giardino armonioso di vita e di relazioni fraterne e pacifiche, di spazio di comunione e di futuro.
Papa Francesco ha detto: “La preghiera è la forza della pace” (Angelus, 23 ottobre 2022). Invito tutti noi stasera a una corale preghiera: tutte le fedi, tutte le confessioni religiose, tutti gli amanti e le amanti del dialogo e della pace, tutti i ricercatori di pace. Una preghiera intesa non come delega di responsabilità che invece ci appartengono, non come uno stucchevole aspettare una soluzione che pensiamo non dipendere da noi. Pregare, stasera, vuol dire concentraci profondamente, rientrare in noi stessi per attingere nella preghiera la nostra forza, quella della profezia della pace. Non si tratta però di un movimento facile e a buon mercato.
Per compierlo siamo chiamati infatti, in primo luogo, a tenere viva la memoria dell’orrore del secolo delle guerre mondiali. Non possiamo essere di nuovo catapultati indietro, non possiamo tornare al Novecento. Ricordiamolo a tutti quelli che vogliono rendere la guerra una fonte di guadagno, un flusso economico certo e redditizio. A quelli che vogliono speculare fomentando guerre che creano legioni di poveri a fronte di pochi ricchi, sempre più ricchi e potenti. Non possiamo cominciare se non ascoltando il grido che sale dalle vittime e dalle macerie di ogni guerra, di questa nefasta e assurda guerra che è arrivata non improvvisamente, ma è stata preparata dall’individualismo estremo (qualcuno ha parlato di ‘singolarismo’) seminato da un’economia del profitto che genera “inequità” (Papa Francesco), scarti umani, degrado ambientale e sovvertimento climatico, causa di nuove povertà. Non dimentichiamo che una delle tante tragiche conseguenze delle guerre in atto nel mondo continua a consumarsi nel Mar Mediterraneo, dinanzi all’indifferenza e all’ipocrisia dei paesi europei: la vergogna dei naufragi, dei bimbi e delle donne annegati, dei respingimenti e delle torture nei lager della Libia. Essere oranti significa per noi stasera rimanere accanto a questo dolore muto e immenso, a questa umanità schiacciata e senza voce in ogni Sud del mondo, che viene ferocemente respinta quando, in un numero davvero limitato, simile alla punta di un iceberg, si affaccia alle nostre coste, alle nostre terre, trovando ad accoglierla la retorica stanca e catastrofica della sicurezza, dell’identità, della distinzione tra ‘noi’ e ‘loro’.
Siamo qui stasera donne e uomini di ogni fede. E con il nostro esserci testimoniamo, anche senza saperlo, il cuore di ogni religione. In modi diversi, con sentimenti e riti diversi, la religione dice un incontro, una relazione tra Dio, tra colui che chiamerei l’Altro, e l’uomo. Dice un aprirsi, un rivolgersi, l’esperienza e il desiderio di un ‘ri-volgersi’ dell’Altro nei confronti dell’uomo. Per la salvezza dell’uomo. Nella fede cristiana Dio dà e dona agli uomini e alle donne di buona volontà l’esempio dell’abbassarsi, del suo abbassarsi per incontrare gli uomini e tutte le creature. Dio, in Gesù di Nazareth, scende negli inferi (cfr 1Pt 3,19), che sono anzitutto gli inferi del cuore umano, per aprirlo alla speranza, alla pace. Dio si abbassa perché la donna, l’uomo, il creato raggiungano la loro altezza: l’altezza a cui sono chiamati. L’altezza più alta, il monte più alto. Il monte di Isaia in cui si raduneranno tutti i popoli della terra (cfr Is 2,2), è la pace. Il compito di Dio, il compito dell’Altro, è quello di aiutare ogni uomo, ogni donna di buona volontà a cucire e a ricucire le relazioni perché diventino il tessuto che copre la terra e riscalda tutti. Com’è possibile che l’uomo scelga la guerra? Quale follia colpisce la mente umana? Sembra un vizio inguaribile, un’ossessione millenaria, una droga invincibile.
Poco più di un secolo fa – come sappiamo – Albert Einstein chiedeva a Sigmund Freud (cfr il carteggio in Perché la guerra, 1933), il padre della psicoanalisi, di spiegare come mai l’uomo, pur consapevole del dolore e della distruzione che rappresentano il frutto amarissimo di ogni guerra, [come mai] l’uomo continui a chiudere gli occhi, a decidersi per la guerra. Per quale perverso circuito l’istinto di morte zittisca l’istinto della vita e dei legami affettivi. Rispondendo oggi, un secolo dopo, direi che la follia di chi sceglie la guerra – non esistono guerre giuste, “alienum est a ratione”, la guerra è semplicemente “irrazionale” secondo la Pacem in terris –, ha un solo nome: cecità. Chi si decide per la guerra non vede i bambini che muoiono, le ferite che squarciano i corpi, gli ospedali che traboccano di viventi mutilati, di cadaveri… Non vede che, una volta entrati nel regno della morte, tutti i cadaveri sono uguali, al di là del colore della pelle, della nazione, dell’appartenenza. Perché chi muore ha una sola appartenenza: l’umanità. La patria, o meglio la Madre che a tutti appartiene e alla quale si ritorna è la Terra. La cecità è la causa ultima della guerra. E così la musica dei focolari, le nenie delle mamme e dei papà, i canti dei cuori innamorati vengono zittiti dalle urla di chi è straziato, colpito nel corpo o negli amori, e dai tuoni odiosi dei cannoni che annunciano cumuli di macerie e fossati di morte. Parlo di una cecità profonda. Sappiamo infatti che in primo luogo si vede e si sente con il cuore. In questo senso, ogni dichiarazione di guerra è un infarto dell’umanità, che blocca la circolazione e atrofizza la mente. Come si fa infatti a non capire che non esistono vincitori? E che ogni vittoria è solo una valanga di morti senza motivo? Che tra poco arriverà un’altra guerra, perché la violenza chiama violenza? La catena deve essere spezzata. I veri eroi non sono i guerrafondai spesso osannati o ricordati nei manuali di storia ma coloro che hanno dato la vita per rompere questa catena. Perché – si chiede ancora Einstein – perché l’uomo fa la guerra invece di godere dell’amore? Come si fa a non comprendere – ripetiamo noi stasera – che solo l’amore rende la vita piena e placa la sete di legami? E non il denaro? E non il possesso? E non la spartizione della ‘preda’? E non la conquista ai danni dell’altro? Nessuna guerra rende felici.
Ecco perché stasera vi invito a stare assieme, a riflettere, a pregare. Per tornare alle radici del nostro essere, per riprendere la via della pace. La guerra pare mostrare ai nostri occhi una pervasività, una forza, una perennità che la connettono irrimediabilmente all’umano. Siamo forse gli unici viventi che sanno di dover morire. Perché cerchiamo il brivido di uccidere, di togliere la vita all’altro? Sappiamo di dover morire e invece di lottare per la vita vogliamo esorcizzare il nostro rifiuto della morte dando la morte agli altri. Come se dando la morte agli altri si potesse riprovare la sensazione di essere come dèi, in grado di togliere la vita! È qualcosa di sconvolgente. Eppure, la contemplazione angosciata del demone del male e della violenza non deve renderci “profeti di sventura” (Giovanni XXIII, Gaudet Mater Ecclesia). Prima di essere un mistero, la guerra è una scelta. La cecità che la muove ha un motivo profondo, una sorgente occultata. Per intenderla e per attingere l’energia giusta al fine di contrastarla abbiamo bisogno di tornare al corpo, di tornare ai corpi.
Ripartire dai corpi. Il corpo – lo sapevano già i Romani, lo sapeva Paolo – non vuole scissioni. Funziona solo grazie alle sinapsi che uniscono. E se l’Alzheimer è la scissione, la frantumazione delle sinapsi, allora chi decide la guerra ha una forma di Alzheimer. Nella sua mente le aree dell’accudimento e dell’amore si sono appiattite. E si sono scisse dalle aree della forza, che degenera per questo in violenza. Dobbiamo dirlo: la guerra nasce da una mente ammalata di una forma particolare di Alzheimer, un Alzheimer che fa dimenticare i volti dei bambini, la bellezza delle donne, il vigore degli uomini, la tenerezza saggia degli anziani. Fa dimenticare la fragranza di una mensa condivisa. La freschezza di un sorriso. Il calore di una carezza. Chi dichiara guerra è in preda a una drammatica perdita della memoria. Ha solo un obiettivo: una coazione a ripetere il dare morte, una coazione a distruggere, perché nella sua vita si sono persi o non ci sono mai stati abbastanza i segni profondi e nutrienti dell’umano. Un mio caro amico – il grande teologo Jean-Pierre Jossua – in uno dei suoi faccia a faccia con Dio, si domandava: la malvagità è frutto di “un’infelicità rovesciata in cattiveria”, i grandi criminali, gli uomini votati al male, non sono stati forse bambini infelici? (cfr Se il tuo cuore crede… Il cammino di una fede, 107-106; 116-117). Non cuori destinati alla violenza, ma soggetti toccati da una mancanza radicale da cui nasce un tragico oblio. Forse chi dichiara la guerra ha dimenticato o non ha avuto la carezza tenera di una madre, la carezza forte di un padre. Solo bambini non amati possono dichiarare guerra. Possono essere accecati dall’odio, dal potere. Forse solo bambini non amati possono entrare nel delirio tragico violento e micidiale di giocare a fare gli dèi.
Nei corpi si imprime insomma il sigillo della ‘mancanza’ che genera violenza, che rende ammissibile, praticabile la guerra. Ma solo i corpi possono resistere. Solo ai corpi possiamo fare appello, perché nei corpi abitano le energie più profonde e curative delle ferite del creato. Il nostro compito di costruttori di pace, la nostra via di donne e uomini della pace è in fondo quella di non far sparire dalla terra il canto dolce dei corpi che amano e sono amati. Nell’inferno che viviamo, dobbiamo ricordare a tutti che nel cuore dell’uomo esiste la voglia di amare ed essere amato. Forse il nostro compito è quello di dire a ogni madre e a ogni padre: ama tuo figlio, amalo nella verità, nella pienezza, amalo tanto che il suo corpo diventi corpo d’amore. Ricordare che dove i corpi si mettono assieme per agire sulla società, per rappresentare le istanze altrui, per costruire ‘corpi intermedi’ lì si piantano i semi di una logica della mediazione opposta alla logica della guerra. Ricordare che dove i corpi si riconoscono e dialogano, a partire dalla loro verità, dai loro miti, dai loro racconti, ascoltati e rispettati, lì la guerra è impossibile. Le carezze materne e paterne, le strutture intermedie umane, il dialogo tra i popoli, il dialogo tra le religioni costruiscono le premesse di un mondo nuovo che continuiamo a sperare, a sperare contro ogni speranza, e che continuiamo a ricordare. Il monte alto di Isaia, la città della pace è la nostra patria, non i campi di battaglia. Il suono degli uccelli e dei canti di amore ci appartengono e non il suono delle sirene, non il boato, il fragore delle armi.
Per questo siamo a chiamati a dire, a gridare, che la partita non sarà mai vinta dalla morte. La vita risorge. Perché ogni corpo per nascere vuole una forza che riscalda, un calore che accoglie. Tutti i bambini nati in questi mesi in Russia e in Ucraina continuano ad essere i veri vincitori che aspettano la vittoria completa, che anticipi la completa distruzione. Tutti le madri che hanno partorito lungo questi mesi ci ricordano la strada che gli umani non vogliono imboccare. Il corpo della donna deve entrare come realtà e come metafora nella polis, nella città degli uomini. Il corpo della donna. Il luogo in cui il maschile e il femminile diventano nuova vita, il corpo in cui si dà la coesistenza di due corpi diversi, senza crisi di rigetto. Il corpo della donna è il corpo della pace. Il corpo dell’uomo maschio è stato per secoli il corpo della guerra. Abbiamo bisogno di “imparare a vivere senza ammazzare” (Guccini, Auschwitz). “Non gli uni contro gli altri, non più, non mai” (Paolo VI, Discorso alle Nazioni Unite, 1965)
Mettiamoci allora stasera sulle orme dei grandi testimoni della non violenza, di coloro che hanno gettato il loro corpo nell’agone della pace e ne hanno fatto il grembo di una vita nuova: da Mahatma Gandhi a Martin Luther King, da Tsunesaburo Makiguchi e Jōsei Toda a Pino Puglisi. Il cantiere della pace ha bisogno di audaci tessitori del dialogo, di costruttori di ponti di riconciliazione. Abbiamo bisogno di dialogo internazionale e di dialogo feriale. Per questo dobbiamo pregare stasera, ognuno come sa, come può. Io innalzo la mia preghiera a Dio, davanti a voi, come il mio tassello, il mio symbolon di una preghiera ben più grande che sale da tutti voi e da tutta la creazione, immersa nelle doglie del parto di un mondo nuovo (cfr Rm 8,19-23):
O Signore
di ogni donna e di ogni uomo credenti in un Altro,
dentro di noi, al di là di noi,
Signore dai tanti nomi.
Noi sappiamo che tu comprendi tutte le lingue
ma ne parli una sola:
la lingua dell’amore e della pace,
la lingua dell’amore per la vita e per l’uomo.
Sappiamo, o Signore, che il dialogo tra le religioni
si ricompone e diventa dialogo di salvezza.
Noi ti abbiamo sempre invocato come
Grande, Onnipotente.
Adesso sappiamo che questo Dio,
il Dio che governa il mondo come un re governa il suo dominio,
è morto.
Si, Dio è morto.
In ogni dichiarazione di guerra
noi uccidiamo Dio.
E lui ci lascia soli.
Soli sulla terra.
Soli a ricordare agli uomini e alle donne
che Tu non muori
fin quando noi grideremo ancora
Pace, paix, peace, shalom, salam, amani, paz…
A ricordare a noi stessi e agli altri
che la Tua presenza è invisibile
e ridiventa visibile ogni volta che operiamo la pace,
ogni volta che creiamo riconciliazioni
nei corpi e tra i corpi,
nelle case e tra le case,
nei popoli e tra i popoli.
È vero: tu non sei morto.
È morto il nostro modo di pensarti.
Non sei morto.
E quando siamo uniti tra di noi,
quando cerchiamo la pace –
lo sappiamo – noi Ti sentiamo.
Noi crediamo che non sei morto
ma hai conosciuto la morte.
Tu sai quanto è amara la morte,
quanto sono terribili gli inferi
E tuttavia ci lasci negli inferi e nella morte,
perché vuoi
che ogni uomo e ogni donna
si diano la mano,
vuoi che ci diamo la mano
in questo mistero della vita che ci sovrasta,
per mantenere accesa anche una fiammella.
Quella che manterrà viva la speranza che
solo la vita genera vita.
Signore, Dio nostro,
nascosto e vicinissimo,
guardando al nostro fratello Gesù,
al suo modo di raccontarti a noi,
sappiamo intimamente che
la morte nel suo corpo è morta,
che l’odio nel suo traboccante amore è morto,
che la vendetta nel suo perdono è morta.
Tutte le guerre, tutte le inimicizie sono morte
nel suo corpo innalzato sulla croce per amore.
In quel corpo squarciato
è stata ricucita la speranza della pace
che con l’audacia dei miti annunziamo:
Dio, in ogni suo Nome,
è la nostra pace. Amen.