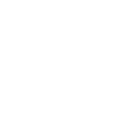Dies Academicus in occasione del decennale dell’elezione
ad Arcivescovo Metropolita della Chiesa di Dio pellegrina in Palermo
di Mons. Corrado Lorefice
Incontro promosso dalla Fondazione per le Scienze Religiose
in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, la Libera Università “Maria Ss. Assunta” e la Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”
Giovedì 30 ottobre Palazzo Steri, sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, ha ospitato il Dies Academicus in occasione del decennale dell’elezione ad Arcivescovo metropolita della chiesa di Dio pellegrina in Palermo di Mons. Corrado Lorefice. L’incontro, promosso dalla Fondazione per le Scienze Religiose in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, la Libera Università “Maria Ss. Assunta” e la Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, ha intrecciato le riflessioni del prof. Andrea Riccardi e del prof. Alberto Melloni su “Pace e dialogo a 60 anni dal Vaticano II” attraverso l’analisi della Dichiarazione conciliare “Nostra Aetate” (approvata dal Concilio il 28 ottobre del 1965) sulle relazioni della Chiesa con le altre religioni non cristiane e le riflessioni offerte da Mons. Corrado Lorefice attraverso un messaggio “tra Vangelo e Costituzione” in cui gli elementi del Vaticano II e l’insegnamento di Giuseppe Dossetti sono stati costantemente presenti.
I lavori, introdotti da Alessandro Pajno, Presidente della Fondazione per le Scienze Religiose, sono stati accompagnati dai saluti offerti da Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Francesco Bonini, Rettore della Libera Università Maria SS. Assunta, Vito Impellizzeri, Preside della Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo.
Discorso di Mons. Corrado Lorefice per il Dies Academicus
nel Decennale di elezione ad Arcivescovo di Palermo
Palazzo Steri, 30 ottobre 2025
Delle cattedrali dei poveri che si innalzano / invisibili nella nebbia nessuno parla.
Sono in cerca delle tue città segrete. / Il tuo regno è qui, nascosto nelle cattedrali dei poveri.
- Mosca Mondadori
Care Amiche e Cari Amici,
buongiorno a tutti voi. Vi ringrazio di cuore di essere qui. Rivolgo un ringraziamento speciale al Presidente della Regione Sicilia, al Sindaco di Palermo, al Rettore dell’Università di Palermo e al Rettore della LUMSA, al Preside della Facoltà Teologica di Sicilia e al Presidente della Fondazione per le Scienze Religiose, al Signor Prefetto, a tutti i Servitori delle Istituzioni, civili, militari e accademiche, nonché al prof. Andrea Riccardi e al prof. Alberto Melloni per l’intensa e coinvolgente riflessione che ci hanno offerto. Sono profondamente onorato di questo Dies academicus organizzato per il decennale della mia elezione ad Arcivescovo di Palermo, e lietissimo che esso coincida con la memoria dei sessant’anni della Dichiarazione conciliare Nostra aetate (28 ottobre 1965). Una memoria celebrata in un luogo così prestigioso come Palazzo Steri, spazio simbolico di un sapere accademico teso tra antico e moderno, tra rigore e creatività, fra tradizione e innovazione, in un dinamismo volto alla formazione integrale dei giovani, alla loro crescita, al loro ingresso poietico nel mondo. È con questi pensieri e con questi sentimenti che stamattina vi parlo e vi saluto brevemente.
Sono arrivato a Palermo dieci anni fa. Quando mi presentai a voi, alla Città, in Piazza Pretoria, quel 5 dicembre del 2015, avevo idealmente in una mano il Vangelo e nell’altra la Costituzione. Era un binomio naturale, direi inevitabile per me, dato che l’autore decisivo della mia formazione e dei miei studi scientifici era stato don Giuseppe Dossetti. Ecco, il Vangelo e la Costituzione.
Il Vangelo era ed è il motivo per cui sto in mezzo a voi. Ma che cos’è il Vangelo? Credo che su questo punto si giochi il senso stesso della presenza ecclesiale nella città degli uomini, per come la teologia del Vaticano II l’ha intesa e interpretata. Il Vangelo infatti non è una mera dottrina, non è un insieme di norme né la fonte immediata di una morale, tanto meno l’ispirazione diretta di una politica. Il Vangelo non è un possesso da conquistare né un’arma da brandire. Il Vangelo non separa, non distingue, non discerne il grano dalla zizzania, non è il vessillo di nessuna battaglia e di nessuna identità. Il Vangelo non è un libro per i puri, né una parola per i sicuri di sé. Non è una verità da sistematizzare né una logica riconducibile alla ragione naturale. Non è un sistema filosofico né può essere la sorgente di un monolite dogmatico senza storia. Questo perché il Vangelo è un racconto. È il racconto della fede (G. Ruggieri) di Gesù di Nazareth, un giovane uomo nato in Galilea e morto in croce a Gerusalemme, un uomo che è stato bambino, ha avuto due genitori e una grande famiglia, ha scoperto il senso di una presenza speciale di Dio nella sua esistenza, fino a farglielo chiamare ‘Papà’ (Abbà), e per questo ha intrapreso un cammino nella Palestina del tempo, dopo essere stato discepolo di Giovanni Battista. Lungo le strade della sua terra ha annunciato la prossimità di Dio agli uomini e in particolare agli ultimi e ai disperati, portando una buona notizia – la notizia del Regno di Dio –, che grazie a un’audace donna cananea (una sorta di Antigone dei Vangeli) ha capito, un giorno, essere rivolta non solo ai Giudei ma a tutti gli uomini, a quelli che erano ritenuti cani, pagani, i goîm, il popolo delle genti (cfr Mt 15,21-28). Su questa fede nel suo Abbà e in forza di questa notizia ha raccolto intorno a sé dei discepoli, ha vissuto un’esistenza da vero amante della vita, da amico delle donne e dei bambini, da compagno dei pubblicani e delle prostitute, e si è consegnato alla sua passione per gli uomini, verosimilmente il 15 di Nisan del 37 d.C., confidando nell’energia di risurrezione annidata nella sua morte e dunque esaltata dal Padre suo, la mattina di Pasqua. Da lì è scaturita una pluralità di eventi, di tradizioni, di irruzioni di Dio, che hanno interpretato e portato nel mondo e nel tempo la storia di quest’uomo di Nazareth. Non l’uomo in generale, non un ‘dio’ come una categoria del pensiero, ma quest’uomo determinato, in cammino accanto al Padre, condotto dalla dynamis dello Spirito, dal dinamismo della vita che ci supera e ci proietta avanti (A. Sichera). È questo, se volete, lo scandalo del Vangelo. Affermare con coraggio intrepido e con incredibile candore che l’esistenza di Gesù di Nazareth, l’esistenza di un uomo, di ‘questo’ uomo, «l’esserci per altri di Gesù» (D. Bonhoeffer), ci ha raccontato Dio, ce ne ha fatto l’esegesi, come dice meravigliosamente il Vangelo di Giovanni: «ἐκεῖνος ἐξηγήσατο», lui ci ha spiegato Dio (Gv 1,18). In questo senso – lo sapeva bene Paolo VI – il Vangelo, se vogliamo pensarlo come un manuale, altro non è che «un manuale di umanità». E dove c’è l’umano c’è Dio, e dove c’è Dio non può non esserci l’umano, il corpo vivente, senziente, amante, aperto agli altri, che ci costituisce nel profondo e che Gesù di Nazareth ci ha mostrato nel racconto forte e vibrante delle prime comunità dei credenti.
È da questa porta che arrivo alla Costituzione. Perché anche la Costituzione nasce da un racconto. Un racconto di liberazione di un popolo, come era stato il racconto dell’Esodo. Un piccolo libro nato da un lungo travaglio, da un incrocio di miseria e di grandezza, di aneliti e di cadute. Uno scritto profetico, espressivo del desiderio profondo di pace e di giustizia che alberga nel cuore degli umani e che – a sentire il Paolo della Lettera ai Romani, al capitolo 8 – risiede e grida con potenza nel grembo stesso della creazione tutta. Perché abbiamo sbagliato a contrapporre per secoli l’ordine della creazione e l’ordine della redenzione. Il mondo creato buono da Dio è il mondo delle creature, del loro dinamismo e della loro fioritura, segno di una presenza e testimonianza di un bene che la distanza non sfigura ma fa semplicemente anelare alla pienezza. È il mondo la prima ‘parola di Dio’, la luce di un dire che si incunea nel caos dell’informe, nell’abbandono del deserto, per conferire un’energia creativa ed esplosiva, in cui Dio si mostra all’opera nel coraggio della differenza, nello spazio della relazione. L’umano e la creazione tutta sono sotto la benedizione di Dio. Ce lo ricorda e lo canta Francesco d’Assisi nel sublime Cantico delle Creature che ha iniziato la poesia italiana. Questo significa che ogni movimento vitale o simbolico del creato è sotto il segno della bontà divina, della Berakah b’shem YHWH, la benedizione nel nome di Dio. Credo stia qui il senso profondo della religione e della cultura. Nell’istituzione della vita mondana e nella configurazione necessaria della distanza, della differenza propria della creazione, si apre lo spazio del desiderio, della ricerca del senso e dell’incontro da parte degli umani e, per mezzo loro, di tutte le creature, che nell’uomo si comunicano a Dio (W. Benjamin). È questa tensione verso l’alto, questo voler parlare con Dio, questo primario raccontarsi a Lui che fonda le pratiche originarie dell’arte e della religione umana, come un esprimere e un manifestare in segni un radicale rivolgimento verso l’Altro che ti fonda, che ci fonda. Religione e cultura sono dunque sfere distinte eppure collocate nella medesima sorgente del desiderio, nella stessa tensione, nella comune ricerca d’altri, d’autrui (E. Lévinas) in vista di un incontro, per conferire un senso. Lo ha ribadito lunedì scorso Papa Leone XIV parlando agli studenti delle Facoltà Pontificie quando ha definito il ricercatore, comunque lo si voglia intendere, come uno che vive un’esperienza di grazia, la grazia di «ricevere uno sguardo ampio, che sa andare lontano, che non semplifica le questioni, che non teme le domande, che vince la pigrizia intellettuale e, così, sconfigge anche l’atrofia spirituale».
Da questo punto di vista, ogni anelito di pace e di giustizia, ogni attesa della verità, ogni espressione del desiderio di bene per tutti è cultura, e la Costituzione italiana ne è un esempio fulgido, come un frutto prezioso del travaglio culturale degli umani. Vedo la Costituzione insomma come il punto finale (e pur sempre provvisorio) di un lungo cammino, durato millenni, di Homo sapiens (ma già dei suoi contemporanei e predecessori, dai Neanderthal agli Erecti) verso una autocomprensione profonda di sé, una ricerca di un senso collettivo e individuale dell’esistenza, che approda a un testo sublime per apertura di orizzonti, nato dal cedimento, dalla distruzione, dal rinnovato caos primordiale dei totalitarismi e della seconda guerra mondiale. Dal mio punto di vista, la Costituzione equivale al soffio dello Spirito che fa rinascere l’informe.
Infatti, il senso ultimo dell’Evangelo e della Costituzione è quella fraternità universale, quell’unità del genere umano di cui parla la Dichiarazione Nostra Aetate e che Papa Francesco – discepolo e interprete del suo eponimo, Francesco d’Assisi – ha sviluppato mirabilmente e sapientemente attualizzato nell’enciclica Fratelli tutti. Fratelli tutti è uno dei pilastri della profezia di Francesco, su cui si fonda anche il pontificato di Leone XIV: scommettere sulla salvezza del genere umano e della creazione tutta in forza di una radice comune, di un’arcana familiarità che il Vangelo ha reso tangibile e che fa parte della consapevolezza dei popoli, come un legame che ci supera, come un entanglement originario (per dirla con il linguaggio della fisica quantistica).
Ecco, sono passati dieci anni da quel 5 dicembre 2015 ed è gioco troppo facile bollare come un’illusione venuta meno, come un desiderio frustrato e ormai impossibile, quell’ideale esposizione parallela del Vangelo e della Costituzione sotto il segno della fraternità universale, quale spazio di incontro ultimo e concreto tra la fede cristiana e la cultura degli uomini. Nel 2015 Francesco era stato eletto papa da poco più di due anni e aveva già posto il fortissimo gesto profetico di Lampedusa, a cui seguirà uno sforzo immane di dialogo interreligioso, sulla scia della preghiera di Assisi, di quell’incontro spiazzante e intimamente evangelico del 27 ottobre 1986 voluto da Giovanni Paolo II. Presidente degli USA era allora – nel 2015 – Barack Obama, primo afroamericano della storia, pur tra contraddizioni e ondeggiamenti, sinceramente teso verso la creazione di ponti e di opportunità di dialogo, contro la logica del più forte e l’uso della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti (Obama, ricordiamolo, fece sedere allo stesso tavolo Iran, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Germania insieme agli Stati Uniti e a tutta l’Unione europea per firmare l’accordo sul nucleare iraniano). La percezione della necessità di una svolta ambientalistica della politica mondiale, già propugnata da Obama, sarebbe approdata nel 2019 al Green Deal dell’Unione europea. E così via. Non sono così ingenuo da sostenere che la svolta degli ultimi cinque anni non affondi le proprie radici negli anni precedenti, ma l’incrudelirsi dei governi europei nei confronti dei migranti (con migliaia di morti nel Mediterraneo e sulla cosiddetta rotta balcanica, e con i campi di concentramento libici e tunisini sempre all’opera in virtù dei finanziamenti dell’Europa); la strumentalizzazione delle religioni quali armi diverse ma altrettanto letali di conflitto e di divisione tra i popoli, fino al folle estremismo politico-religioso del movimento MAGA; l’esplosione dell’epidemia di Covid-19 con la lancinante messa in mostra degli squilibri sociali, sanitari ed economici mondiali; il ritorno prepotente della guerra e del diritto del più forte sulla scena internazionale, ben visibile nei conflitti armati che continuano a insanguinare il mondo (dal Congo al Sudan, ecc.), ma rappresentato in maniera altamente simbolica dalla guerra in Ucraina e dal conflitto israelo-palestinese, con il 7 ottobre di Hamas e con il progetto israeliano di distruzione della Palestina; la crisi dell’ambientalismo e l’abbandono della cura della Terra quale stella polare delle politiche planetarie (ovvero l’implementazione delle stesse, in maniera molto problematica, da potenze mondiali come la Cina); il declino del welfare e la scommessa sull’economia di guerra e sulla corsa agli armamenti: sono solo alcuni dei fenomeni macroscopici che dovrebbero far tramontare definitivamente ai nostri occhi la speranza su cui muovevo dieci anni fa i primi passi nella mia e nostra Palermo. Basta aggiungere la situazione disastrosa di una parte della gioventù della nostra Città, tra mancanza di lavoro, dipendenza da sostanze e uso sfrenato delle armi da fuoco, accanto al cinismo affaristico delle organizzazioni mafiose, a cui le istituzioni, compresa la Chiesa, e la politica non riescono a far fronte con la perizia e il coraggio necessari, per avere davanti agli occhi un quadro disperante.
Eppure io credo che non dobbiamo disperare. Non parlo della speranza nell’intervento dei potenti, delle soluzioni possibili per mano di classi dirigenti sempre più asservite o compiacenti rispetto alle logiche della guerra e del conflitto sociale ed economico, dello sfruttamento dei poveri e della madre Terra. No, non è questa la strada della speranza. La mia speranza, che è insieme l’appello con cui voglio concludere il mio intervento, è quella riposta nei movimenti dal basso, generati, come in Congo, dal desiderio di riscatto dei poveri nel Nord Kivu; dalla difesa della Terra, da parte dei giovani dei Fridays for Future; dalla preservazione della comune umanità, dalla difesa della fraternità da parte della gente comune, dei tanti bambini, giovani, adulti e anziani che sono scesi in piazza per fermare la guerra mostruosa di Gaza, inferno insensato per decine di migliaia di donne e bambini; dalla resistenza alla mafia e dalla ricerca di giustizia da parte delle migliaia di persone convenute allo Zen pochi giorni fa dopo i fatti di Palermo. Queste onde, queste maree umane sparse per il mondo, più o meno grandi che siano, sono l’antidoto più efficace che ci sia all’Alzheimer dei potenti, al folle misconoscimento del volto dei poveri e dei piccoli (G. Salonia). Il Vangelo ci dice che sono loro, le vittime innocenti e i loro difensori disarmati il vero asse della storia, mentre la Costituzione pensa alla politica come una cosa pubblica, capace di creare pace e giustizia per tutti. Ed è da lì allora, dal Vangelo e dalla Costituzione, che vogliamo insieme ricominciare. Insieme, se è vero, com’è vero, che «per educare un bambino serve un intero villaggio» (Proverbio africano). Vi ringrazio!