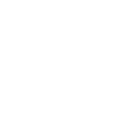Oggi molti cittadini siciliani, molti cittadini italiani, ricordano con molto dolore e molta rabbia la strage di Lampedusa di 10 anni fa, quando 368 persone morirono naufragando a pochi metri dal sogno dell’approdo in una terra che avrebbe dovuto garantire loro il diritto all’accoglienza e in molti casi all’asilo.
Il dolore non è per il ricordo, ancora vivo e inconsolabile, di quei 368 fratelli, ma per tutto ciò che non siamo stati capaci di fare per salvare gli oltre 25000 fratelli che da quel giorno ad oggi sono annegati in questo mare che si è fatto di pietra: un mare che si è fatto muro anziché ponte tra le sponde, che si è fatto cimitero di vite anziché incontro tra le vite.
E la rabbia non è per quest’impotenza, sempre più intenzionale e quindi sempre più imperdonabile, ma per lo scenario che apre davanti a noi: è per ciò che sembra destinato ad accadere ancora nei prossimi dieci giorni, dieci mesi, dieci anni.
Oggi, a Lampedusa, sono assenti i rappresentati del Governo, gli stessi che meno di due settimane fa sono andati lì a snocciolare abusati ed esausti decaloghi di buone intenzioni, in breve tempo tradotti in misure che continuano a barricarci in un mondo sempre più piccolo e miope dal quale gli altri – tutti gli altri – devono essere tenuti fuori, allontananti, respinti. In una parola, per molti di loro: semplicemente condannati a morte.
I rappresentanti del governo, anziché essere a Lampedusa a occuparsi del destino di migliaia di persone in mare e dall’altra parte del mare, preferiscono occuparsi di una persona sola: un giudice di Catania che ha fatto il suo lavoro secondo la legge e secondo coscienza, considerando illegittime – come già lo erano apparse agli occhi di tutti – quelle previsioni del Decreto Cutro che violano sia le norme europee sia innanzitutto la nostra Costituzione.
Appena pochi giorni fa, in occasione del trentesimo anniversario del martirio di Padre Pino Puglisi, ho scritto che se fosse stato ancora oggi tra noi lui sarebbe adesso proprio lì, sul molo di Lampedusa, lo stesso molo su cui furono deposti i 368 cadaveri di dieci anni fa e a cui sono ininterrottamente affidate le trepidazioni e le speranze di centinaia e centinaia di fratelli e sorelle al termine di un lunghissimo viaggio di cui ancora non abbiamo imparato a conoscere fino in fondo sacrificio e sofferenza.
Ecco, proprio come farebbe Don Pino, tutti noi dobbiamo sentirci oggi chiamati su quel molo, ancora una volta non per vuote celebrazioni di strazianti anniversari, ma per assumere un impegno che è di ordine umano ed etico, prima ancora che sociale e politico.
“I migranti vanno accolti, protetti o accompagnati, promossi e integrati”, ci ha appena esortato Papa Francesco a Marsiglia, dove ci siamo ritrovati come Vescovi e giovani delle cinque sponde del Mediterraneo. Tante Nazioni per un unico popolo chiamato alla condivisione degli stessi valori e delle stesse sfide, chiamati ad assumere una definitiva consapevolezza della portata umanitaria ed epocale che racchiude questo esodo di uomini e di donne. Chiamati, soprattutto, a lasciarci contagiare dallo sguardo di Dio che chiede alle nostre comunità di collocare lo sguardo all’altezza dello sguardo dei migranti e dei rifugiati, per rimanere umani e per essere autenticamente cristiani, degni del nome di Cristo, il Messia che libera prendendo e condividendo le sofferenze di tutti gli uomini e di tutte donne, che ha detto: “Ero forestiero e mi avete ospitato. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli, l’avete fatto a me” (Mt 25,35.40). A maggior ragione se ci professiamo cristiani!
+ Corrado Lorefice